La nostra amica archeologa e saggista, Francesca Valbruzzi, ci propone oggi un dialogo con Giuliano Volpe, autore impegnato a costruire ponti tra l’archeologia, come scienza e come pratica, e la società tutta.
Un impegno che Volpe persegue oggi nel ruolo di docente all’Università di Bari e che ha perseguito in passato quando è stato rettore dell’Università di Foggia, Presidente del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici del MiBACT, negli anni dal 2014 al 2018, e poi consigliere del ministro Franceschini fino al 2020.
Lo testimonia il suo ultimo libro “Archeologia pubblica. Metodi, tecniche, esperienze” (collana Studi Superiori, Carrocci editore, Roma 2020), in cui vengono illustrate le “buone pratiche” condotte negli ultimi decenni dagli archeologi in tutti i territori italiani. Pratiche volte, non solo a divulgare, nel modo più accessibile a tutti, gli esiti delle ricerche archeologiche, ma anche a coinvolgere direttamente le comunità locali nella progettazione. Solo così esse potranno divenire pienamente consapevoli di quale sia il valore sociale del patrimonio culturale nella costruzione del presente e del futuro del nostro Paese.
Francesca Valbruzzi
Gli archeologi sono considerati nel nostro Paese come figure retrograde: nel migliore dei casi come studiosi chiusi in una torre d’avorio che si dilettano a spolverare reperti antichi senza alcuna connessione con il mondo reale, nel peggiore come “guastafeste” che bloccano la realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo economico per meri interessi corporativi.
Il suo libro, invece, fa emergere le recenti azioni di rilevanza sociale della “Archeologia Pubblica” frutto del ripensamento del proprio ruolo da parte dei “professionisti dei beni culturali”, come li definisce la norma che ne tutela lo status nel Codice dei Beni Culturali (articolo 9bis).
Molte di queste “Buone Pratiche” sono state realizzate in Sicilia dai funzionari archeologi in servizio nel sistema regionale di tutela, che hanno saputo realizzare progetti culturali in sinergia con il mondo scientifico, le Università e con le comunità locali.
Cosa ritiene che si debba fare perché questi esempi virtuosi non rimangano casi isolati ma divengano sistematici, anche attraverso il giusto riconoscimento del ruolo professionale degli archeologi nell’amministrazione regionale?
Giuliano Volpe
Penso che ogni stagione abbia la sua archeologia. C’è stata la lunga fase elitaria dell’archeologia identificata solo con l’antiquaria e la storia dell’arte antica, poi la fase della rivoluzione stratigrafica e della nascita sul campo della figura dell’archeologo professionista, con i grandi cantieri urbani, la fase delle tecnologie, dell’informatica, delle scienze naturali. Credo che quella che viviamo sia la fase dell’archeologia pubblica, che però non deve essere confusa solo con la comunicazione o l’organizzazione di eventi, con una pagina facebook o un profilo Instagram e nemmeno solo con un Open day di uno scavo.

C’è anzi il rischio concreto di una banalizzazione dell’archeologia pubblica, in mano ad archeologi pasticcioni e solo desiderosi di visibilità mediatica, che stanno producendo danni gravi all’archeologia con una comunicazione fatta di sensazionalismo, di scoperte straordinarie, cioè anteponendo la “scoperta” alla “ricerca” e così facendo riportano indietro le lancette dell’orologio della nostra disciplina, che ha richiesto molti anni per affermarsi come scienza e professione.
L’archeologia pubblica intende, invece, fare dell’archeologia un elemento di sviluppo culturale, sociale ed economico della società contemporanea. Richiede, quindi, che gli archeologi studino il passato essendo però attivi e impegnati nel presente, e che soprattutto mettano in campo strategie per sviluppare la partecipazione attiva, non solo nella fase finale di fruizione, ma fin dall’inizio, cioè dalla fase di progettazione di una ricerca. Gli archeologi dovrebbero essere veri mediatori, anzi “interfacce” per usare un termine a noi caro, tra la materialità del passato e le persone che vivono nel presente.
Facendo riferimento a due importanti Trattati europei sul patrimonio culturale, si tratta di coniugare la Convenzione de La Valletta del 1992, che pose al centro giustamente la figura scientifica e professionale dell’archeologo, con la Convenzione di Faro del 2005, che pone al centro le “comunità di patrimonio”. Insomma, si tratta di svolgere un ruolo sociale ancor più forte da parte degli archeologi, peraltro secondo una tradizione propriamente italiana, che ha visto archeologi sempre molto impegnati, ben prima che si parlasse di archeologia pubblica: mi limito a citare solo Ranuccio Bianchi Bandinelli e Riccardo Francovich.
Quanto alla situazione siciliana, che mi fa molto soffrire, conosco bene l’eccellente lavoro svolto da tanti colleghi nelle soprintendenze, nei musei, nei parchi, nelle università. Oggi la situazione è davvero preoccupante e richiede misure urgenti e di sistema. In passato non nascondo di aver guardato con interesse al modello siciliano per proporre al ministro il passaggio dalle soprintendenze settoriali alle soprintendenze uniche, “olistiche”, territoriali. Certo non immaginavo che si riducessero a non avere quasi più competenze specifiche disciplinari al loro interno e che non ci fossero più dirigenti archeologi! Ho fatto parte per un po’ del Consiglio Regionale dei beni culturali e c’è stato un momento con Sebastiano Tusa assessore in cui si stavano progettando iniziative molto interessanti e innovative. Poi la situazione è cambiata e mi auguro che possa esserci presto un cambio di rotta.
Francesca Valbruzzi
Sono in particolare le nuove generazioni che hanno dato impulso al nuovo modo di intendere il lavoro dell’Archeologo come “mediatore culturale” che racconta il passato remoto, dando voce ai contesti e ai reperti disseppelliti, in modo comprensibile e accessibile a tutti, per renderlo utile al presente.
Purtroppo, però, le giuste aspettative di lavoro dei professionisti dei beni culturali rimangono spesso disattese e molti giovani archeologi formati nelle Università italiane sono costretti a cercare miglior fortuna all’estero o a cambiare mestiere per sopravvivere. La situazione è particolarmente grave in Sicilia dove la Regione non bandisce concorsi per funzionari archeologi da ben 25 anni. Cosa si dovrebbe fare, secondo Lei, per invertire la rotta?
Giuliano Volpe
Per raggiungere questo obiettivo è necessario costruire un’alleanza degli archeologi con la società siciliana. È soprattutto necessario superare definitivamente una visione proprietaria del patrimonio culturale che contribuisce a accentuare il divario. La tutela purtroppo è ancora sentita in larghi settori della società non come la cura di un bene comune ma come un impedimento allo sviluppo economico, per gli ostacoli, i ritardi, i mille problemi che pone in occasione di lavori edili o agricoli, di costruzione di infrastrutture, di trasformazioni del territorio, a volte – bisogna ammetterlo – anche per improprie ‘esagerazioni’, non giustificate dalla legittima e sempre necessaria azione di conoscenza e tutela del patrimonio.
Bisognerebbe ribaltare questa immagine, modificando la percezione diffusa del patrimonio culturale, da ‘problema’ a grande ‘risorsa’ per la Sicilia (senza peraltro cadere nella insopportabile retorica della Bellezza!) e per il suo sviluppo sano. Ed è necessario, altresì, affermare, nella stessa comunità degli specialisti dei beni culturali, l’idea che le risorse archeologiche sono anche risorse economiche perché contribuiscono al ‘benessere’, alla ‘qualità della vita’, alla felicità, cioè al ‘wellbeing’ e al ‘welfare’. Anche per questo è sempre più necessario misurare il valore sociale ed economico del patrimonio archeologico, perché tale ‘valore’ può rappresentare la misura di quanto sia importante il patrimonio culturale per la società.
Dopo aver dibattuto lungamente sul ‘come’ bisognasse tutelare i beni archeologici e sul ‘chi’ dovesse occuparsene, l’attuale scenario culturale siciliano, italiano ed europeo ha ben chiaro che la reale durabilità/sostenibilità dei beni si gioca sulla capacità di spiegare il ‘perché’ conservare, il ‘per chi’ farlo, e sul potenziale ‘valore’ del patrimonio archeologico anche come veicolo di crescita economica e sociale e di miglioramento diffuso della qualità della vita.
Nel campo della comunicazione archeologica si sono fatti progressi ma anche se la situazione va progressivamente ulteriormente migliorando, capita ancora spesso, anche in musei e parchi siciliani, di osservare visitatori che si aggirano spaesati tra vetrine debordanti di oggettti o un groviglio di muretti incomprensibili, in preda a un senso di inadeguatezza.
I supporti didattici sono spesso poco chiari, di fatto riservati solo a specialisti o a un pubblico particolarmente colto. Ai ‘visitatori normali’ si concede al massimo una sorta di contemplazione acritica che riesce a far esprimere ammirazione (‘che bello!’), oppure la partecipazione al rito delle foto e dei selfie davanti alle opere ‘feticcio’ (si pensi al telamone di Agrigento), da condividere sui social network, senza quel piacere della conoscenza che solo strumenti e linguaggi comunicativi adeguati riescono a trasmettere, in maniera efficace e stimolante. Prevalgono ancora verbosi pannelli e didascalie iper-tecniche che quasi nessuno capisce e che pochissimi leggono.
Attenzione: la buona comunicazione non può prescindere dalla buona ricerca, ma la buona ricerca da sola non può sempre garantire necessariamente una comunicazione efficace. Però deve essere chiaro a tutti che solo una ricerca metodologicamente rigorosa e un’affidabile analisi e interpretazione dei dati possono garantire un racconto capace di produrre una reale crescita culturale insieme al piacere dell’esperienza conoscitiva.
Proprio per questi motivi il ruolo dell’archeologo, con specifiche competenze anche in ambito comunicativo, è fondamentale, per riuscire ad affermare il giusto equilibrio tra le esigenze mediatiche e ciò che il ricercatore stesso intenda comunicare, con un racconto che renda semplice (e non banale) ciò che è complesso, unitario ciò che è frammentario.
Leggi anche, tra gli altri, Salvatore Settis, guardare al passato per progettare il futuro
Agrigento, dove il passato e il presente si fronteggiano
Beni culturali, tra sfruttamento ‘mercantile’ e necessità di un nuovo approccio



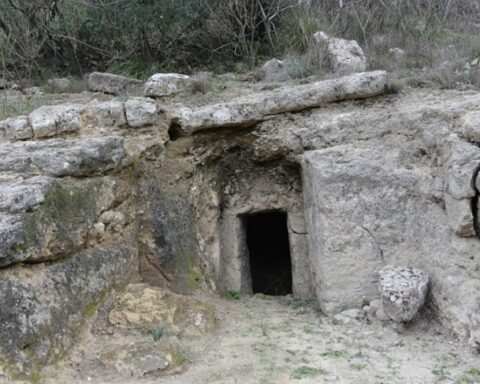
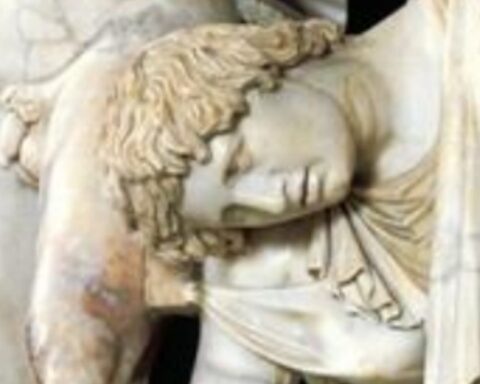





Bellissimo articolo, meriterebbe seguire il problema senza perderlo di vista.
Molto interessante questa iniziativa, penso che l’archeologia sia importante sia come scienza e sia x il suo apporto al progresso della democrazia parlandoci del movimento e della mescolanza tra i vari popoli, scambio fra le varie culture , e anche per il superamento dell’identità come un dato acquisito alla nascita a sempre fisso nel tempo, concetto che oggi sta creando molti danni se non egoismi disumani