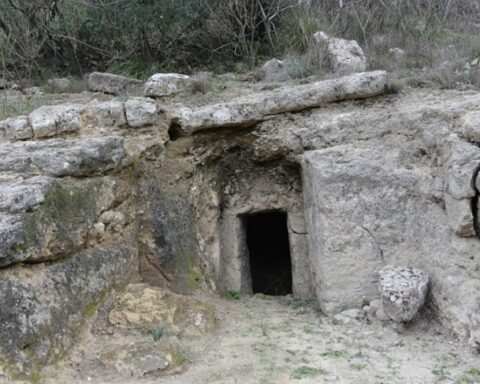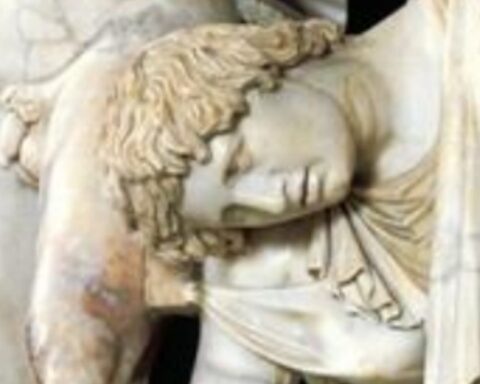Catania vuole candidarsi a Capitale della cultura 2028? Pare proprio di sì, tanto che il Comune sta preparando un dossier con tutte le credenziali cittadine.
Noi vorremmo contribuire a questa raccolta di informazioni sui meriti culturali della nostra città e soprattutto sull’impegno delle nostre istituzioni locali per far crescere la conoscenza diffusa e prendersi cura delle strutture a questo finalizzate, a partire dalle biblioteche.
Partiamo, quindi, dalla domanda su cosa stia facendo questa amministrazione e cosa abbiano fatto le amministrazioni precedenti per le biblioteche cittadine, vale a dire per i luoghi deputati alla promozione della cultura e al coinvolgimento attivo dei cittadini.
Lasciamo parlare i numeri. A Catania, oltre la biblioteca centrale, Vincenzo Bellini, che ha due sedi, in via Sangiuliano e in via Spagnolo (al 529 di via Etnea), c’erano, fino al 2015, 10 biblioteche decentrate in vari quartieri.
Ebbene, ora le biblioteche decentrate sono solo tre: ‘Livatino’ in via Leucatia, ‘Tondo Gioeni’ in via Etnea, ‘Pigno’ all’interno del centro commerciale Porte di Catania.
Le altre sono state chiuse. La biblioteca ‘Leonardi Grassi’ di Corso Indipendenza e la ‘Picanello’ di via Galatioto, per la necessità di lasciare locali che non erano di proprietà comunale, la biblioteca di Nesima (via Felici) in attesa di un piano di ripristino mai avvenuto, la biblioteca ‘Giuseppe Montana’ di via Galermo per infiltrazioni d’acqua.
Sono state chiuse per mancanza di personale le altre tre, vale a dire la biblioteca ‘Monte Po’ in via Vigo, la biblioteca San Giorgio-Librino in stradale San Giorgio e la biblioteca ‘Concordia’ in via Plaia.
Quest’ultima era collocata all’interno degli spazi del Centro Culturale ex Concordia, immobile ristrutturato con l’utilizzo dei fondi del progetto Urban, laboratorio sperimentale di rigenerazione economica, ambientale e sociale in quartieri degradati con alto tasso di disagio minorile. Ed era, in effetti, una biblioteca al servizio di una comunità particolarmente fragile. Ora non c’è più.
In verità la mancanza di personale non è un valido motivo per la chiusura delle biblioteche perchè si può sopperire sottoscrivendo convenzioni con il Terzo Settore, come avviene, ormai da anni, in altre città. Il Comune di Catania non ha mai voluto prendere in considerazione questa possibilità, nonostante che, trattandosi di enti no profit, avrebbe solo l’onere di stipulare le assicurazioni per i volontari.
Il totale del patrimonio librario (volumi ed opuscoli) delle Biblioteche civiche catanesi chiuse è di 32.273 volumi ed opuscoli (dati estrapolati dal sito dell’ICCU, l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane). E non si conosce il luogo in cui sia attualmente collocato questo patrimonio.
Nel febbraio 2024 (quando la situazione era migliore di quella attuale) i consiglieri comunali del Movimento 5Stelle hanno presentato in proposito un’interrogazione, ma le Direzioni interpellate hanno risposto in modo generico, sostenendo che il materiale fosse stato distribuito nelle altre biblioteche cittadine.
C’è dell’altro. In una delle bibliotechee ancora aperte, la biblioteca Vincenzo Bellini di via di Sangiuliano, si sono perdute le tracce della Biblioteca Americana “John F. Kennedy” (fondo USIS), donata al Comune di Catania si presume nei primi anni sessanta. Si presume perchè oggi non è più rintracciabile tutto quello che era facilmente leggibile su internet.
Un’altra problematica inerente le Biblioteche cittadine riguarda le giornate di apertura al pubblico. Di sabato mattina nessuna di esse è accessibile. Eppure, essendo le scuole dell’obbligo ormai chiuse di sabato, bambini e ragazzi potrebbero essere convolti in attività formative organizzate in questi luoghi di lettura. Sarebbe un modo per arginare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa, di cui la nostra città ha un triste primato.
Nel 2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) ha emesso un bando per realizzare attività culturali finalizzate alla rigenerazione urbana, con la denominazione “Progetto Biblioteca Casa di Quartiere” una delle azioni del Piano Cultura Futuro Urbano, nato per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia. Un Piano d’azione di 25 milioni di euro che finanziava la realizzazione di nuovi servizi per migliorare la qualità della vita, soprattutto in contesti caratterizzati da marginalità economica, infrastrutturale e sociale, donando nuova personalità a scuole e biblioteche.
In particolare, venivano finanziati progetti che mirassero a diversificare e ampliare l’offerta culturale, grazie all’apertura nelle fasce orarie e nei giorni festivi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, società civile organizzata, artisti e creativi.
La Biblioteca Bellini, collocata nella I Municipalità, insiste su un territorio che presentava il 15,8% di laureati e diplomati, il 43% di popolazione immigrata e alti tassi di dispersione scolastica. Tanto è vero che in Biblioteca, da diversi anni, si svolgono corsi di lingua italiana per stranieri e vi è stata trasferita una raccolta di testi dedicata alle varie etnie, proveniente dalla ex Casa dei Popoli, finanziata con il progetto Urban e fortemente voluta dall’allora assessore alla Cultura, Antonio Di Grado.
Il progetto “Casa di Quartiere” venne annunciato con enfasi, nell’autunno del 2019, dall’assessora Mirabella, che annunciò – tra l’altro – che sarebbe stato utilizzato anche “uno spazio in disuso la cui manutenzione rientra nel finanziamento concesso”.
Catania era stata, infatti, tra i vincitori del bando ed ebbe un finanziamento di 80.000 euro con cui furono anche acquistati giochi educativi e strumenti musicali.
L’avvio del progetto fu promettente. Si svolsero un corso di dizione, mostre e laboratori, di fotografia, di scenografia, di recupero di oggetti, di uso del verde, con la collaborazione di associazioni attive sul territorio. Fu persino organizzato un coro multietnco con la collaborazione dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini.
Dopo la chiusura dovuta alla pandemia di Covid, le attività furono concluse frettolosamente per non perdere i finanziamenti e la biblioteca Bellini tornò ad essere quello che era prima, un luogo di consultazione di libri, audiovisivi e giornali, ma con orari di accesso sempre più ridotti, sempre con il pretesto della mancanza di personale.
Con buona pace dell’attenzione che l’Amministrazione dovrebbe avere per la diffusione della Cultura a tutti gli strati della popolazione e in particolare tra i giovani dei quartieri più fragili.
Lo abbiamo constato di recente quando abbiamo appreso che i fondi del decreto Caivano bis, destinati a fronteggiare degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel quartiere di San Cristoforo (che costituisce una parte della I Municipalità), saranno utilizzati per rendere più “invitanti” percorsi da dedicare al turismo, divenuto ormai interesse prevalente dell’attuale amministrazione.
Il materiale acquistato con il finanziamento del progetto “Casa di quartiere”, non sappiamo dove si trovi attualmente. Quello che era stato dichiarato in possesso della Biblioteca al momento della presentazione del progetto, si trova oggi presso la sede della Biblioteca di via Etnea: le sezioni Musicale, Cinematografica, Mediatica, Emeroteca, Integrazione multiculturale, sei postazioni computerizzate e la possibilità di consultare cd rome e audiovisivi (746 testi di musica, 383 di cinema). In via Sangiuliano è rimasta la sezione Locale e l’archivio del quotidiano ‘La Sicilia’, a partire dal 1952 ad oggi.
Non essendoci più alcuna Casa di Quartiere, ma solo una normale Biblioteca, il Ministero, se solo volesse, potrebbe riavere indietro il finanziamento concesso. Non interrompere la mission del progetto era, infatti, una delle condizioni che permettevano la candidatura. Invece è rimasta solo una targa informativa imposta dal Ministero, attualmente affissa nel locale in disuso annesso alla biblioteca, che è stato oggetto di manutenzione e avrebbe dovuto “accogliere attività organizzate da privati senza la presenza dei dipendenti comunali”.
Si pensava di metterlo a disposizione degli artigiani, insieme ad alcuni strumenti tecnologici, per promuovere la creazione di una partnership tra autorità locali, piccoli imprenditori, associazioni di categoria e cittadini, gruppo di lavoro per future proposte urbane sostenibili da proporre all’amministrazione comunale. Nulla di tutto questo. Questo locale accoglie attualmente il servizio di scambio libri trasferito dal Palazzo della Cultura. Non un servizio in più per la città, ma un servizio in meno.
Un servizio in più che oggi sarebbe utile e che è ormai presente nella maggior parte delle biblioteche cittadine è l’accesso al catalogo, digitalizzato, da remoto. Permetterebbe agli utenti di conoscere i libri di cui la biblioteca è in possesso, senza doversi recare in loco per effettuare la ricerca del testo desiderato. Un servizio che non c’è.
Detto tutto questo, è comprensibile che susciti ilarità la notizia che il Comune di Catania intenda candidarsi a “Capitale italiana della Cultura 2028”.
E’ interessante sapere che la Giunta per essere “accompagnata” nella redazione e presentazione del “dossier di candidatura” ha cercato un operatore qualificato. Tra le manifestazioni di interesse pervenute è stata considerata più valida quella del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) PTSCLAS e Melting Pro Lerning. Ci costerà la modica cifra di 130.000 euro circa.
Per concludere. Tra i criteri per la valutazione delle candidature troviamo, “il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione dell’azione; la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini di assistere o partecipare ad attività culturali, soprattutto giovani, volontari e gruppi emarginati o svantaggiati”, compresi minoranze e disabili. Siamo, quindi, in trepidante attesa di essere coinvolti nella preparazione della candidatura così come è avvenuto in altre circostanze (sic!).
E siamo curiosi di sapere come farà “l’operatore economico” a dimostrare, alla Giuria che dovrà valutare i progetti, quanto sia spiccato l’interesse verso la Cultuta dimostrato da chi governa la città.
(Non avremmo potuto scrivere questo articolo senza la preziosa collaborazione di Cinzia Colajanni, che ringraziamo).